Un breve racconto. È Natale.
La neve cadeva da un tempo imprecisato, non abbastanza da trasformare davvero la strada, ma quanto bastava per renderla meno decisa, e mentre camminavo sentivo i passi affondare appena, quel tanto che serviva a rallentare il corpo senza costringerlo a fermarsi, come se il terreno stesse suggerendo un ritmo diverso, più attento, più lungo. Il cappotto di lana cotta verde mi avvolgeva fino alle ginocchia e il suo peso, compatto e continuo, non gravava sulle spalle ma le teneva occupate, ricordandomi a ogni movimento che il corpo era lì, presente, inserito in quella sera fredda senza esserne respinto, con l’odore leggermente umido del tessuto che saliva quando respiravo più a fondo e si mescolava all’aria tagliente.
Le mani restavano nelle tasche, chiuse non per difendersi ma per aderire a quella protezione spessa, ruvida, che non isolava del tutto il freddo ma lo rendeva distante, come qualcosa che si può sentire senza doversene occupare, e intanto le luci delle case scorrevano ai lati, finestre accese dietro vetri appannati, frammenti di stanze che apparivano e sparivano senza chiedere attenzione, scene già iniziate che non avevano bisogno di spettatori, e in quel passare lento sentivo che ogni passo non stava portando verso qualcosa, ma si stava semplicemente aggiungendo al precedente, uno dopo l’altro, senza accumulo, senza fretta.
Ed il suono dei miei passi cambiava continuamente, ora più ovattato, ora più secco, a seconda di dove la neve aveva deciso di fermarsi, e in quel dialogo muto tra suola e asfalto c’era una continuità che mi teneva dentro il movimento, impedendomi di pensare davvero, lasciando che fossero il respiro, il peso del cappotto, l’oscillazione regolare del corpo a guidare l’andare. Non stavo andando incontro alla cena, non ancora, quella restava lontana, indistinta, come una stanza di cui si conosce l’esistenza ma non la disposizione, e questo mi permetteva di restare in quel tratto di strada come se non fosse un passaggio, ma una condizione.
Mi accorsi che stavo rallentando senza volerlo, non per stanchezza, per una specie di accordo silenzioso con la sera, come se affrettarsi avrebbe spezzato qualcosa che non aveva un nome, e mentre mi fermai un istante, solo per sentire meglio il silenzio che la neve stava costruendo attorno, ebbi la sensazione che quel camminare fosse già parte di ciò che sarebbe venuto dopo, non un prima, non un’introduzione, ma un modo di arrivare che lasciava spazio, che non stringeva.
Il cappotto seguiva il passo con una fedeltà antica, oscillando appena, e in quel movimento continuo, senza inizio né fine riconoscibili, capii che non stavo semplicemente attraversando la strada, ma mi stavo lasciando attraversare da quella sera, dal freddo, dalla neve che cadeva piano, come se tutto stesse rallentando insieme a me, il tempo compreso, per permettere qualcosa che non aveva bisogno di essere capito, solo abitato.
La casa arrivò senza annunciarsi, semplicemente smise di essere lontana, e quando mi fermai davanti alla porta la neve aveva già lasciato una traccia sottile sulle spalle del cappotto, un’umidità leggera che non dava fastidio ma ricordava il percorso appena fatto, come se il fuori non avesse alcuna intenzione di restare completamente fuori. Bussai con un gesto breve, quasi distratto, e mentre aspettavo sentii il rumore attutito di voci dall’interno, non parole distinguibili, solo un intreccio di suoni che avevano già una temperatura diversa, più calda, più densa.
La porta si aprì e l’aria cambiò di colpo, non in modo brusco ma come quando si entra in un luogo dove il tempo è stato trattenuto più a lungo, e il calore mi avvolse senza cancellare del tutto il freddo che avevo addosso. Entrai, richiusi alle spalle, e per un istante rimasi fermo, non per esitazione ma per assestamento, lasciando che il corpo capisse dove si trovava. Il cappotto pesava di più ora, impregnato di neve che iniziava a sciogliersi lentamente, e mentre lo slacciavo sentivo la lana cedere appena, come se si rilassasse anche lei.
Lo appesi insieme agli altri, una fila di tessuti scuri, spessi, ciascuno con una forma leggermente diversa, e in quel gesto semplice ebbi la sensazione di deporre qualcosa che non era solo un indumento, ma una distanza necessaria. Le voci si fecero più vicine, i volti emersero uno a uno, non tutti insieme, ma come accade quando la luce si abitua gradualmente agli occhi, e riconobbi le posture prima ancora delle espressioni, chi occupava lo spazio con naturalezza, chi restava leggermente indietro, chi parlava già mentre qualcun altro stava ancora pensando a cosa dire.
La stanza della cena era illuminata da una luce calda che non cercava di nascondere nulla, ma nemmeno di evidenziarlo, e il tavolo stava al centro come un punto di convergenza inevitabile, apparecchiato con una cura silenziosa, senza eccessi, con piatti che sembravano già pronti ad accogliere ciò che sarebbe arrivato. Mi sedetti mentre le conversazioni riprendevano il loro corso, come se la mia presenza fosse stata prevista, non attesa ma prevista, e qualcuno mi chiese se avevo trovato freddo, una domanda che non richiedeva davvero una risposta.
«Sì,» dissi, «ma niente di strano,» e la frase scivolò via, si appoggiò alle altre senza lasciare segno. Il cibo cominciò ad arrivare, portato con gesti lenti, e il vapore che saliva dai piatti si mescolava all’odore della casa, creando uno spazio intermedio in cui le parole sembravano muoversi con più cautela. Le persone si aggiustavano sulla sedia, qualcuno si rimboccava le maniche, qualcuno sistemava il tovagliolo con un’attenzione che tradiva un’abitudine antica, e in quei piccoli movimenti riconobbi una familiarità che non aveva bisogno di essere nominata.
Si parlava mentre si mangiava, non di cose precise, ma di ciò che affiora quando il tempo non incalza, frasi che cominciavano senza sapere dove sarebbero finite, racconti che si allungavano, venivano interrotti, ripresi da un altro punto, e io ascoltavo sentendo che il ritmo della cena stava lentamente sostituendo quello della strada, senza cancellarlo, semplicemente inglobandolo. Ogni tanto qualcuno mi chiamava in causa, chiedeva cosa ne pensassi, e rispondevo senza fretta, lasciando che le parole trovassero il loro posto, consapevole che non stavamo cercando accordi, ma una forma di permanenza condivisa.
Il tempo, lì, non avanzava in linea retta, si disponeva attorno al tavolo come una presenza discreta, permettendo ai silenzi di allungarsi quanto bastava, alle frasi di tornare su se stesse, e mentre il piatto si svuotava lentamente capii che la cena di Natale non era un momento da attraversare, ma uno spazio da abitare, con tutto ciò che portava con sé, le differenze, le esitazioni, le parole dette a metà. Restai seduto, mangiai, parlai, ascoltai, e sentii che l’onda non si era fermata, aveva solo cambiato temperatura, continuando a muoversi sotto la superficie delle cose.
Il cibo continuò ad arrivare senza fretta, come se la cucina avesse deciso di adeguarsi al ritmo della stanza, e mentre i piatti venivano passati di mano in mano il tavolo cominciò a funzionare come una superficie comune, un luogo dove le parole potevano appoggiarsi senza cadere subito. Le facce erano illuminate dal basso, dai riflessi dei piatti chiari e dei bicchieri, e questo dava ai lineamenti una morbidezza insolita, attenuava gli spigoli, rendeva meno evidenti le espressioni troppo nette. Qualcuno mangiava con attenzione, masticando lentamente, qualcun altro parlava tenendo la forchetta sospesa, come se il gesto potesse aspettare che il pensiero trovasse una forma accettabile.
A un certo punto una voce, non la più forte, non la più sicura, disse qualcosa che non sembrava destinata a restare, una frase detta quasi per riempire uno spazio, e invece aprì una piega nella conversazione.
«È strano come ogni anno sembri uguale, eppure non lo è mai davvero.»
Nessuno rispose subito. Qualcuno annuì, qualcun altro continuò a mangiare come se non avesse sentito, ma la frase rimase lì, sospesa sopra il tavolo, e dopo un po’ un’altra voce la riprese, spostandola appena.
«Forse perché siamo noi a non essere più gli stessi.»
«Ma lo siamo mai stati?» disse qualcun altro, con un sorriso che non cercava consenso. «Intendo davvero. Uguali a noi stessi.»
La domanda non era retorica, ma non pretendeva nemmeno una risposta definitiva. Io sentii che mi riguardava, non più degli altri, ma in modo diverso, come se mi stessero chiedendo non di spiegare, ma di espormi un poco. Appoggiai la forchetta, non del tutto, la lasciai inclinata sul piatto, e dissi che forse il problema non era cambiare, ma accorgersene solo in certi momenti, quando ci si ritrova seduti allo stesso tavolo e il confronto diventa inevitabile.
«A me pesa questa cosa,» disse qualcuno, spostandosi leggermente sulla sedia, «questa idea che qui si debba sempre fare il punto della situazione.»
«Non lo facciamo sempre,» rispose un’altra voce, più calma. «Lo facciamo quando non possiamo evitarlo.»
«E perché non possiamo evitarlo?»
«Perché ci vediamo poco,» dissi. «E quando succede, succede tutto insieme.»
Il dialogo prese una forma più estesa, meno difensiva. Non c’erano accuse, ma posizioni che si delineavano con chiarezza crescente, come se il calore della stanza permettesse finalmente alle parole di allungarsi senza irrigidirsi. Qualcuno parlò a lungo, raccontando una sensazione più che un fatto, la fatica di tenere insieme le cose, la tentazione di semplificare, di ridurre tutto a formule gestibili. Qualcun altro rispose non contraddicendo, ma spostando il discorso di lato, dicendo che forse quella fatica era il prezzo da pagare per non scivolare nell’indifferenza.
Io ascoltavo e parlavo a mia volta, non cercando di mediare, ma di restare dentro il flusso, accettando che alcune frasi mi convincessero solo a metà, che altre mi restassero addosso senza che sapessi bene perché. Notai i gesti, una mano che stringeva il bicchiere un po’ troppo a lungo, un dito che seguiva distrattamente il bordo del piatto, un’espressione che cambiava appena quando una parola toccava un punto scoperto. Il cibo intanto si raffreddava, veniva ripreso, abbandonato, e questo alternarsi di attenzione e distrazione faceva parte della stessa conversazione.
«Forse il Natale serve solo a questo,» disse a un certo punto qualcuno, con una voce più stanca che ironica, «a creare un contesto in cui possiamo dire cose che altrove non troverebbero spazio.»
«O a ricordarci che quel contesto è fragile,» rispose un altro. «E che non dura.»
Non ci fu malinconia in quella frase, solo una constatazione lucida. Continuammo a mangiare, a parlare, a fermarci, e sentii che la cena stava compiendo il suo lavoro silenzioso, non quello di unire o separare, ma di tenere aperta una possibilità, quella di restare seduti abbastanza a lungo da non dover fingere che tutto fosse semplice. Il tavolo, con le sue macchie leggere, i piatti quasi vuoti, i bicchieri segnati, diventò il centro di un tempo diverso, un tempo che non chiedeva di essere risolto, solo attraversato insieme.
La frase rimase sospesa solo per un attimo, poi qualcuno, seduto non proprio di fronte a me ma abbastanza vicino da costringermi a incrociarne lo sguardo, prese la parola con una lentezza che non era esitazione, ma scelta. Aveva una camicia chiara, le maniche arrotolate con cura, come se avesse deciso fin dall’inizio che quella sera non avrebbe avuto bisogno di protezioni, e parlava tenendo la voce bassa, costante, senza cercare l’attenzione del tavolo intero.
«Io non so se è vero che qui diciamo cose che altrove non diremmo,» disse, guardando il piatto più che le persone, «a me sembra piuttosto che qui finiamo per dire sempre le stesse, solo con parole leggermente diverse, come se girassimo attorno a un punto che conosciamo bene ma che continuiamo a evitare.»
Nessuno lo interruppe. Anche chi stava mangiando rallentò, come se avesse riconosciuto che quella frase aveva bisogno di spazio. Io sentii che mi riguardava, non perché fosse diretta a me, ma perché toccava qualcosa che stavo pensando senza riuscire a formularlo.
«Forse è vero,» risposi dopo un momento, «ma non credo che sia un evitare. Credo piuttosto che sia un modo per restare vicini senza dover arrivare per forza a una conclusione.»
Lui sollevò finalmente lo sguardo. «Ma non ti stanca?» chiese. «Questo restare sospesi. Questo non dire mai fino in fondo.»
«Mi stancherebbe di più il contrario,» dissi. «Il dire tutto, una volta sola, e poi non doverci più tornare.»
Fece un mezzo sorriso, curioso. «Io invece ho l’impressione che a forza di non dire, di non chiudere, finiamo per accumulare una specie di rumore di fondo. Non litigioso, nemmeno triste, ma continuo. E alla lunga pesa.»
Il tavolo restava in ascolto, ma senza irrigidirsi. Qualcuno beveva, qualcun altro spostava il piatto, e quei gesti non rompevano il filo, lo accompagnavano. Sentii che quello scambio non chiedeva adesione, ma presenza, e mi sporsi leggermente in avanti, appoggiando gli avambracci sul tavolo.
«Forse pesa perché pretendiamo che queste sere facciano qualcosa che non possono fare,» dissi. «Che chiariscano, che sistemino, che risolvano. Io non credo che servano a questo.»
«E a cosa servirebbero, allora?» chiese lui, senza provocazione.
«A durare,» risposi. «A stare seduti abbastanza a lungo da non doverci spiegare. A ricordarci che possiamo condividere uno spazio anche senza un accordo.»
Restò in silenzio per un attimo, come se stesse valutando non tanto la risposta, quanto il tono. Poi scosse leggermente la testa. «Vedi,» disse, «io non sono sicuro che basti. Restare, intendo. A volte ho l’impressione che restiamo per abitudine, non per scelta.»
«Ma l’abitudine non è il contrario della scelta,» dissi. «È una scelta che si è sedimentata.»
Qualcuno al tavolo fece un gesto impercettibile, come un cenno di assenso, ma nessuno intervenne. Lui riprese, più lentamente: «Io ho paura che queste cene ci permettano di rimandare. Di dire, sì, ne parleremo, lo faremo, cambieremo, e poi passa un altro anno.»
Non risposi subito. Lasciai che la frase si posasse, che facesse il suo lavoro. Guardai i volti attorno, le espressioni concentrate, la stanchezza che cominciava a farsi vedere senza diventare pesante, e pensai che quella paura non era estranea a nessuno di noi.
«Forse hai ragione,» dissi infine. «Ma forse non è un rimandare. Forse è accettare che alcune cose non hanno un momento giusto, e che forzarle sarebbe peggio.»
«Quindi non fare nulla?»
«Non nulla,» risposi. «Fare questo. Essere qui. Non scappare.»
Lui sospirò piano, non di insofferenza, ma come se avesse riconosciuto qualcosa che non gli piaceva del tutto, ma che non poteva negare. «È che io vorrei uscire da qui sentendo di aver capito qualcosa in più.»
«Io invece mi accontento di sentire che non ho capito meno» dissi.
Ci fu una breve risata, non liberatoria, ma condivisa, e in quel momento lo scambio si chiuse da solo, non perché avessimo esaurito l’argomento, ma perché aveva detto tutto ciò che poteva dire senza trasformarsi in un confronto sterile. Il resto del tavolo riprese a parlare, lentamente, come se nulla fosse accaduto, eppure sentii che qualcosa si era spostato, non risolto, ma riconosciuto.
Continuammo a mangiare, con una calma nuova, e il dialogo rimase lì, non come una verità, ma come una traccia, una linea sottile che attraversava la cena senza bisogno di essere seguita da tutti.
Per un po’ si parlò d’altro, o almeno così sembrava, perché le frasi che circolavano avevano preso una qualità diversa, come se fossero state toccate da qualcosa che non le riguardava direttamente ma che le rendeva più lente. Qualcuno fece un’osservazione pratica, su quanto fosse cotta la carne, su come forse andasse girata prima, e nel dirlo si fermò a metà, sorrise, aggiungendo che alla fine andava bene così, che non era il caso di correggere tutto all’ultimo momento, e quella frase, detta quasi per caso, fece annuire più di una persona.
Un’altra voce, più distante, disse che forse il problema non era capire o non capire, ma riconoscere quando era il momento di smettere di cercare una risposta, e lo disse senza enfasi, come se stesse parlando di qualcosa che aveva imparato suo malgrado. Nessuno replicò, ma qualcuno sollevò il bicchiere, bevve un sorso più lungo del necessario, e lo posò con attenzione, come si fa quando si vuole marcare una pausa senza dichiararla.
Io sentivo ancora addosso lo scambio di prima, non come una frase precisa, ma come una tensione sottile, e mi accorsi che anche gli altri, a modo loro, lo stavano assorbendo. Le parole continuavano a passare, ma ora si fermavano un istante in più prima di essere dette, come se ognuno stesse verificando il peso di ciò che stava per aggiungere, non per censura, ma per misura.
Qualcuno disse, quasi tra sé e sé, che in fondo il bello di queste sere era che non chiedevano prestazioni, e un’altra voce rispose che forse era proprio questo a renderle difficili, perché non offrivano scuse. La conversazione non si riaccese, non tornò sul punto, ma quell’idea restò lì, come un fondo comune, e il tavolo sembrò raccoglierla senza bisogno di commenti.
Riprendemmo a mangiare gli ultimi bocconi, con una calma che non era stanchezza ma una forma di rispetto per ciò che era appena passato. Sentii che non c’era altro da aggiungere, non perché fosse stato detto tutto, ma perché il resto avrebbe avuto bisogno di un altro tempo, di un altro luogo. La cena stava lentamente esaurendo la sua funzione, non per mancanza di parole, ma perché aveva fatto quello che poteva fare, tenere aperto uno spazio, permettere a qualcosa di risuonare senza obbligare nessuno a seguirlo fino in fondo.
Il silenzio non arrivò come una sospensione netta ma come una lenta sottrazione, una parola che non venne detta e poi un’altra che non servì più, e mentre qualcuno stava ancora masticando e qualcun altro teneva la forchetta a mezz’aria, il tavolo cominciò a riempirsi di una quiete densa, non vuota, fatta di piccoli rumori che prima non avevano spazio, il contatto del metallo sul piatto, il legno che scricchiolava appena sotto il peso dei gomiti, il respiro che trovava finalmente un ritmo comune. Nessuno sembrava a disagio, ma nessuno cercava nemmeno di intervenire, come se tutti avessero riconosciuto nello stesso istante che parlare ancora avrebbe significato forzare qualcosa che aveva appena trovato una forma provvisoria, e così ci si muoveva con cautela, si beveva lentamente, si piegava il tovagliolo più del necessario, non per educazione ma per rimanere dentro quel tempo allargato che la cena aveva prodotto senza dichiararlo.
La luce restava ferma, non più complice delle parole, ma testimone silenziosa dei volti che ora si mostravano per quello che erano, stanchi senza essere sconfitti, presenti senza dover dimostrare nulla, e io sentivo che quel silenzio non cancellava lo scambio di prima, non lo metteva da parte, ma lo lasciava decantare, togliendogli l’urgenza di una risposta, come se fosse finalmente possibile accettare che alcune frasi non servono a chiudere, ma solo a restare aperte abbastanza a lungo da non farci sentire soli. Il cibo ormai finito lasciava sul tavolo segni minimi, una briciola, una macchia chiara sulla tovaglia, un coltello spostato di lato, e nessuno sentiva il bisogno di sistemare, perché anche quell’imperfezione faceva parte di ciò che stava accadendo, di quella tregua fragile in cui si poteva semplicemente essere lì, senza ruolo, senza posizione da difendere.
Qualcuno posò il bicchiere con un gesto lento, quasi attento a non rompere l’equilibrio, qualcun altro si appoggiò allo schienale lasciando andare le spalle, e in quel rilassarsi collettivo si avvertì una stanchezza condivisa che non chiedeva di essere nominata, una stanchezza buona, come quella che arriva quando non c’è più nulla da dimostrare. Io restai fermo, le mani davanti a me, sentendo che quel silenzio era simile alla neve fuori, non una fine ma una copertura leggera, qualcosa che smussava, che rendeva possibile il passaggio successivo senza imporlo, e capii che la cena stava terminando proprio lì, non nel momento in cui qualcuno si sarebbe alzato o avrebbe parlato, ma in quel punto esatto in cui tutti sapevamo, senza dirlo, che restare ancora avrebbe significato cambiare stanza, cambiare temperatura, lasciare che l’onda continuasse altrove.
Qualcuno si alzò lentamente, non di scatto, non per impazienza, ma con quella cautela che si usa quando si ha la sensazione che ogni gesto lasci una traccia, e il rumore lieve della sedia che arretrava sul pavimento sembrò più forte di quanto fosse davvero, non perché disturbasse, ma perché segnava un passaggio. Nessuno lo guardò subito, non per disinteresse, ma per rispetto di quel movimento che non chiedeva attenzione, e mentre la figura restava in piedi per un attimo, come in attesa che il corpo decidesse il passo successivo, il silenzio si adattò, si spostò leggermente, lasciando spazio senza dissolversi. Qualcuno inspirò più a fondo, qualcun altro si mosse sulla sedia, e io sentii che quel semplice alzarsi stava facendo ciò che le parole non avevano fatto, indicava che il tempo della cena si stava chiudendo senza bisogno di dichiararlo, che l’onda non si fermava ma cambiava direzione.
La persona rimase un istante così, in piedi accanto al tavolo, le mani appoggiate allo schienale, lo sguardo che non cercava nessuno in particolare, e poi disse, a bassa voce, quasi come se parlasse più alla stanza che agli altri, che forse era il momento di spostarsi di là, che il fuoco doveva essere ormai pronto. La frase non aveva la forma di un invito, né quella di una decisione, e proprio per questo venne accolta senza commenti, come se fosse stata pronunciata da tempo e solo allora fosse diventata udibile.
Le sedie cominciarono a muoversi una dopo l’altra, non tutte insieme, ma seguendo un ritmo irregolare che però trovava una sua armonia, i bicchieri vennero lasciati sul tavolo, qualcuno raccolse il tovagliolo e lo posò con un gesto distratto, e in quel lento disgregarsi sentii che nulla di ciò che era stato detto veniva abbandonato, semplicemente cambiava postura. Mi alzai anch’io, senza fretta, avvertendo il leggero indolenzimento delle gambe dopo essere rimasto seduto a lungo, e mentre facevo un passo indietro ebbi la sensazione che il tavolo restasse lì a custodire tutto, le parole, i silenzi, le esitazioni, come una superficie che aveva assolto al suo compito.
Ci muovemmo verso l’altra stanza seguendo percorsi brevi, incrociandoci senza urtarci, e mentre il silenzio continuava ad accompagnarci, ora meno denso ma ancora presente, capii che non si era spezzato nulla, che l’onda stava semplicemente cambiando temperatura, preparandosi a raccogliere il calore del fuoco e il gesto lento di un bicchiere versato, senza perdere ciò che aveva portato fino a lì.
Il fuoco era acceso da un po’, lo si capiva non tanto dalle fiamme quanto dal modo in cui la stanza aveva già modificato l’aria, rendendola più morbida, meno tesa, e quando ci avvicinammo sentii subito il calore arrivare alle gambe, salire lentamente, come fa una bevanda forte quando scende senza bruciare. Le fiamme non erano alte, non cercavano spettacolo, si muovevano con una pazienza antica, piegandosi, ritirandosi, tornando, e il loro riflesso scivolava sui volti, cambiandoli di continuo senza fissarli mai, facendo apparire e scomparire ombre leggere sotto gli occhi, lungo le guance, sulle mani che ora si muovevano con meno cautela. Qualcuno prese i bicchieri, li distribuì senza contare, e l’Armagnac venne versato lentamente, con un gesto che aveva qualcosa di cerimoniale pur restando semplice, il liquido ambrato che si raccoglieva sul fondo del vetro e sembrava trattenere la luce del fuoco, restituendola più scura, più profonda.
Ci sedemmo, non tutti nello stesso modo, qualcuno vicino al camino, qualcuno leggermente discosto, e io sentii il corpo adattarsi di nuovo, il cappotto ormai lontano, il calore che scioglieva lentamente ciò che era rimasto contratto, non solo nei muscoli ma nel modo di stare. Le conversazioni ripresero, ma non dove si erano fermate, scivolarono, diventarono più frammentate, più personali senza diventare intime, come se il fuoco permettesse alle parole di perdere struttura senza perdere senso. Qualcuno raccontò un ricordo che non cercava precisione, un’immagine sfocata, un dettaglio sbagliato che nessuno corresse, e mentre parlava teneva il bicchiere tra le mani come se quel calore fosse necessario per continuare, e qualcun altro rise piano, non per la battuta ma per il riconoscimento di qualcosa che gli apparteneva anche se non era stato nominato.
Bevvi un sorso, l’Armagnac scese lento, caldo, lasciando dietro di sé una scia che si allargava, e pensai che quel bere non serviva a dimenticare, ma a rendere più tollerabile il restare, a permettere al silenzio di tornare senza diventare pesante. Il fuoco continuava il suo lavoro, costante, e in quel movimento irregolare ma fedele sentii che la serata stava entrando in una fase diversa, non di chiusura, ma di allentamento, come se tutto ciò che era stato detto potesse ora riposare, mescolarsi, perdere i contorni netti senza dissolversi. Restammo lì, a parlare a tratti, a tacere spesso, lasciando che il calore facesse il suo corso, e capii che quella era la parte della sera in cui non si costruisce più nulla, si custodisce soltanto, senza sapere bene cosa, ma con la certezza che valeva la pena farlo.
Qualcuno guardò l’orologio senza commentare, come se il gesto fosse più per sé che per gli altri, e subito dopo un’altra voce disse qualcosa di pratico, che fuori faceva ancora freddo, che la neve non aveva smesso, e quella constatazione, detta senza intenzione di concludere, cominciò a muovere lentamente la stanza. I bicchieri vennero posati uno alla volta, non tutti insieme, l’Armagnac rimase sul fondo come una traccia calda che nessuno cercò di finire, e le conversazioni si ridussero a frammenti, frasi lasciate a metà, sorrisi brevi che non chiedevano risposta, come se il fuoco avesse ormai fatto il suo lavoro e potesse essere lasciato a se stesso.
Mi alzai insieme agli altri, non prima né dopo, seguendo un tempo che non apparteneva a nessuno in particolare, e sentii il corpo protestare appena, una rigidità lieve che tornava alle ginocchia, alle spalle, come un promemoria gentile. Attraversammo la stanza senza urgenza, recuperando giacche, sciarpe, cappotti, e quando presi il mio, il lungo cappotto di lana cotta verde, lo sentii diverso, non più solo pesante ma pieno, come se avesse trattenuto qualcosa del calore appena lasciato, e mentre lo infilavo le maniche mi sembrarono meno rigide, più disponibili ad accompagnare il movimento.
I saluti furono semplici, senza frasi definitive, qualche parola sul rivedersi, senza date, senza promesse, e nessuno cercò di prolungare quel momento più del necessario. La porta si aprì, l’aria fredda entrò senza violenza, decisa ma pulita, e per un istante il contrasto fu netto, il respiro che si accorciava, il viso che si tendeva appena, poi tutto trovò di nuovo un equilibrio. Uscimmo uno alla volta, lasciando dietro di noi la luce del camino che continuava a muoversi, indifferente alla nostra partenza, fedele al suo ritmo.
La strada mi accolse come se non fosse passato del tempo, la neve cadeva ancora, uguale e diversa, e i primi passi furono più attenti, il corpo che ritrovava il passo, il cappotto che oscillava con una familiarità rinnovata. Le finestre illuminate scorrevano di nuovo ai lati, ma ora non mi sembravano scene separate, piuttosto variazioni dello stesso interno che avevo appena lasciato, e in quel camminare sentii che la sera non chiedeva bilanci, non pretendeva conclusioni, permetteva solo di portare con sé ciò che era accaduto senza doverlo sistemare.
Il rumore dei passi tornò a essere ovattato, regolare, il respiro si adattò al freddo, e mentre avanzavo capii che nulla era stato risolto, nulla chiarito davvero, eppure qualcosa si era spostato, non in avanti ma di lato, come quando si cambia posizione per continuare a guardare la stessa cosa da un’angolazione appena diversa. Continuai a camminare, lasciando che la neve coprisse piano le tracce, senza fretta di arrivare, con la sensazione quieta che quella sera non avesse bisogno di essere ricordata in modo preciso, perché aveva già fatto ciò che poteva fare, rendere il tempo, per un tratto, abitabile.
E fu così, semplicemente andando, che tornai a casa.


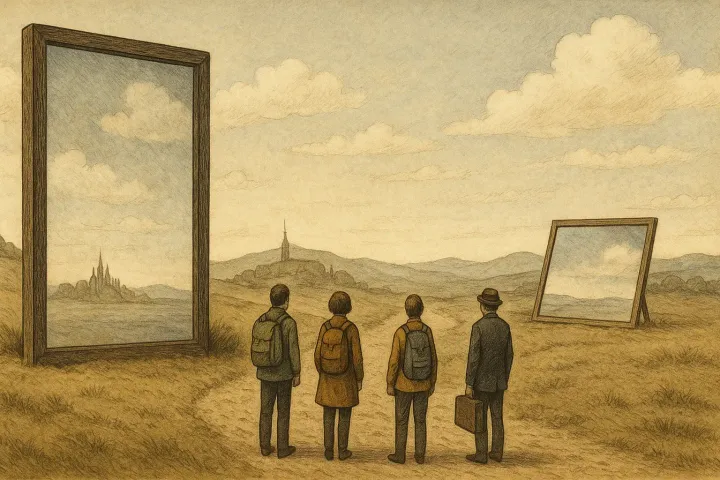
Comments ()