Ho cominciato a viaggiare senza motivo e mi sono ritrovato in un mondo che funziona male ma con logica impeccabile. Così nasce la Guida turistica all’inutile: un diario realistico di luoghi impossibili.
Non saprei dire quando ho deciso di partire. Forse non l’ho deciso affatto.
Certe partenze non cominciano con una scelta, ma con una stanchezza che diventa curiosità.
Avevo passato settimane a lavorare, dormire male, rimettere a posto cose che non avevano bisogno di essere aggiustate. Ogni giorno sembrava la copia corretta di quello prima. Poi, una mattina, ho sentito il bisogno preciso di andare via, non verso qualcosa, ma lontano da tutto il resto.
Ho aperto una mappa digitale e ho lasciato che fosse il cursore a scegliere per me.
Il nome che è comparso sullo schermo era Capitalconfusione. Non l’avevo mai sentita nominare. Non compariva nei motori di ricerca, ma c’era una stazione, un orario e un treno in partenza di lì a poco.
Non avevo motivi per andarci, e nessuno per restare. Ho preso lo zaino con il minimo indispensabile: un taccuino, una camicia pulita, un libro che non avrei letto ed una penna bic con l'inchiostro blu.
Mi sono seduto al binario sbagliato, e il treno giusto è arrivato lo stesso.
Non avevo idea di dove sarei finito.
Ma in quel momento non mi interessava capirlo: volevo solo vedere se, da qualche parte, il mondo avesse ancora qualcosa da raccontare, anche a chi non stava più facendo domande.
Quello che segue è il mio taccuino di viaggio.
Ho cercato di scrivere tutto come l’ho visto: le città, le persone, gli animali, gli oggetti, persino i silenzi.
Se qualcosa vi sembrerà assurdo, vi prego di credermi: era proprio così.
Diario di viaggio
Il treno entrò in stazione con un fischio breve, come se avesse fretta di ripartire. Non avevo mai sentito parlare di Capitalconfusione ma il nome sul tabellone mi era sembrato sufficientemente neutro per scendere.
Sul binario non c’era nessuno, solo un carrello con una ruota mancante e un cartello arrugginito che diceva “Uscita, salvo variazioni improvvise”.
Seguii la freccia. Dopo pochi metri, la passerella finiva contro un muro. Tornai indietro e trovai un’altra scala che scendeva. Portava a un piccolo atrio con le pareti di vetro sporco e una biglietteria deserta. Dentro la cabina, un uomo leggeva un giornale di due anni prima. Mi guardò, poi tornò a leggere, come se fossi arrivato troppo tardi per fargli cambiare idea.
Fuori, la città mi accolse con un rumore continuo, simile a quello dell’acqua che scorre in un tubo. Era una giornata calda, ma il cielo non sembrava convinto.
Sul marciapiede, un taxi con il cofano sollevato e il motore che girava a vuoto. L’autista, un uomo corpulento con un cappello da baseball e una camicia troppo stretta, mi fece segno di salire.
«Funziona?» chiesi.
«Abbastanza per arrivare dove serve», disse, chiudendo il cofano con un colpo secco. «Dove la porto?»
«In centro.»
«Bene. Speriamo che oggi esista.»
Il viaggio durò una ventina di minuti, ma la città sembrava cambiare ogni volta che giravamo un angolo. Alcuni palazzi erano nuovi, lucidi, pieni di insegne; altri sembravano sventrati da decenni. Su una facciata, un’enorme scritta pubblicitaria diceva: “CAPITALCONFUSIONE — QUI SI TROVA QUEL CHE NON SERVE.”
Il tassista non parlava molto, ma ogni tanto faceva osservazioni pratiche: “Quel quartiere lo hanno costruito per sbaglio. Doveva essere un parcheggio.”
Alla fine si fermò davanti a un edificio bianco con colonne troppo sottili per reggere qualcosa.
«Ecco, il Grand Hotel del Forse. È centrale, almeno oggi.»
All’interno, l’aria sapeva di pulito recente e di moquette bagnata. La hall era grande, ma semivuota. Sul bancone della reception, un vaso con fiori di plastica deformati dal sole.
La receptionist era una donna giovane, con un viso stanco e un accento indefinibile.
«Buongiorno. Ha una prenotazione?»
«Non credo.»
«Va bene lo stesso.» Mi porse una chiave legata a un portachiavi di metallo grande quanto la mia mano. «Camera 312. L’ascensore si ferma al terzo piano, ma solo se si preme il bottone con convinzione.»
La stanza era semplice: un letto largo, una scrivania, una finestra che dava su un cortile interno pieno di sedie impilate. L’acqua del lavandino usciva tiepida anche sul freddo. Sul tavolo, un foglio dattiloscritto spiegava le regole dell’albergo.
“Non è consentito lasciare la finestra aperta dopo il tramonto.
Non è consigliato restare troppo a lungo davanti allo specchio.
Il minibar contiene solo ciò che si merita.”
Scese una pioggia leggera, improvvisa. Decisi di uscire lo stesso, per esplorare un po’.
Le strade intorno all’hotel erano strette, e le insegne dei negozi sembravano scritte a mano. “BAR PUNTO E VIRGOLA”, “ALIMENTARI TENTATIVO”, “TABACCHI SE NECESSARIO”.
A ogni incrocio, un vigile regolava il traffico con gesti casuali, come se dirigesse una banda immaginaria. Le auto si fermavano e ripartivano senza logica apparente, ma senza incidenti.
Entrai in un bar per asciugarmi. Dentro c’erano quattro persone: un uomo con un impermeabile seduto accanto al frigorifero, una donna che contava ad alta voce le zollette di zucchero, un ragazzo che fissava il soffitto, e un cameriere che si muoveva tra i tavoli con la calma di chi lavora in un sogno.
Chiesi un caffè.
Lui annuì, ma rimase fermo per un minuto intero prima di muoversi. Quando mi servì la tazzina, guardò fuori dalla finestra e disse:
«Di solito a quest’ora piove più convinta.»
«Sembra che non sappia cosa fare.»
«Succede spesso anche alla gente.»
Pagai e uscii. Sul marciapiede, un cane mi seguiva a distanza, fermandosi ogni volta che mi voltavo. Non sembrava perso: sembrava aspettare che fossi io a esserlo.
Più avanti, trovai un parco con una recinzione arrugginita e una targhetta: Ingresso libero, uscita a discrezione.
All’interno, i sentieri si incrociavano senza incontrarsi mai del tutto. C’erano panchine rivolte verso muri, lampioni accesi di giorno e una fontana che spruzzava acqua controvento.
Su una delle panchine sedeva una pecora, con un cappello di paglia e un libro tra gli zoccoli.
Mi fermai, incerto se fingere di non vedere. Lei sollevò lo sguardo e mi disse:
«Turista?»
«Più o meno.»
«Allora non resti troppo. Qui si comincia a prendere sul serio la confusione.»
Sfogliò una pagina del libro e aggiunse: «C’è una buona trattoria due vie più giù. Si chiama Il Pressappoco. Eviti il vino della casa.»
Poi tornò a leggere, come se fossi già diventato un ricordo marginale.
La trattoria era esattamente dove aveva detto.
Un’insegna sbiadita, porte di legno, tovaglie di carta.
Dentro, due tavoli occupati: un uomo che dormiva sul menù e una coppia che discuteva sottovoce sulla direzione delle posate.
Il cameriere mi portò acqua e pane senza che chiedessi nulla.
«Avete un piatto tipico?»
«Sì, ma dipende dai giorni. Oggi serviamo quello che è rimasto da ieri, che però domani sarà ottimo.»
Scelsi “l’assaggio misto”, un piatto con formaggi troppo morbidi e verdure che sembravano arrese. Il sapore era buono, ma con un retrogusto di dimenticanza.
Quando uscì il sole, la città sembrava un’altra. Le persone camminavano più in fretta, ma tutte nella stessa direzione.
Seguii il flusso per qualche minuto, finché si disperse davanti a un grande edificio di vetro, privo di insegne. Dalle finestre si vedevano stanze completamente vuote, ma illuminate. Ogni tanto, qualcuno compariva e restava immobile, come se stesse posando per un ritratto.
Rimasi a guardarli finché il cielo cominciò a scurirsi.
Tornando all’hotel, mi accorsi che le strade non erano più le stesse. I negozi avevano cambiato nome, e al posto del bar c’era una lavanderia che esponeva un cartello: “Ritirate ciò che siete.”
Il portiere dell’hotel mi salutò come se mi conoscesse da sempre.
«Giornata lunga?»
«Sì.»
«Succede. Qui il tempo ha più turni del personale.»
In camera, trovai un nuovo foglio sul tavolo:
“Se sogna qualcosa di strano, la preghiamo di non riferirlo al personale. Potrebbe diventare contagioso.”
Aprii la finestra. Nella strada sotto, un gruppo di ragazzi giocava a pallone con un casco da motociclista.
Ogni volta che lo calciavano, uno di loro gridava “Gol!” anche se la palla non entrava mai da nessuna parte.
Mi misi a scrivere qualche riga sul taccuino, ma non riuscivo a trovare un modo per descrivere la città.
Alla fine scrissi solo:
“Capitalconfusione è un posto dove tutto sembra avere senso finché non ci pensi troppo.”
Spensi la luce.
Da fuori arrivava il suono costante dei passi di qualcuno che non si decideva se andare o tornare.
La mattina dopo, la receptionist era diversa. Una ragazza bionda, capelli raccolti, stava annotando qualcosa su un quaderno. Mi chiese se avevo dormito bene.
«Abbastanza.»
«Ottimo. Qui è raro.»
Mi restituì un documento che non ricordavo di averle dato e mi informò che il treno per l’altopiano partiva “quando si mette d’accordo con sé stesso”.
Chiesi dove fosse la stazione.
«Appena dietro il municipio. Ma se la cerca direttamente non la trova. Cammini come se dovesse andare altrove, e la vedrà.»
La stazione era effettivamente dietro il municipio, o meglio, dentro un cortile pieno di piccioni. Il bigliettaio dormiva con la testa appoggiata al vetro. Sul tabellone, una sola destinazione: Altopiano delle Pecore Filosofe. L’orario: “In partenza appena possibile”.
Mi sedetti ad aspettare.
Dopo una ventina di minuti arrivò un treno corto, due vagoni appena, color crema. Nessuno scese. Il capotreno, un uomo magro con la barba perfettamente divisa a metà, mi fece cenno di salire.
Durante il viaggio, il paesaggio cambiò con calma. Le case scomparvero, sostituite da campi bassi, colline piatte e recinzioni piegate dal vento. Ogni tanto, piccoli gruppi di pecore immobili come statue.
Il treno si fermò in un punto senza stazione. Il capotreno aprì la porta e disse:
«È qui.»
«Dove, esattamente?»
«Non saprei. Ma qui funziona.»
Il terreno era duro, coperto da erba corta e lucida. Davanti a me, un sentiero di ghiaia saliva verso un gruppo di case basse.
Un cartello in legno, scolorito, portava scritto:
“Benvenuti sull’Altopiano. Si prega di pensare lentamente.”
Camminando, notai che tutto sembrava perfettamente pulito. Le staccionate dritte, i prati tagliati alla stessa altezza.
C’erano persone — uomini e donne — vestite con abiti semplici, che camminavano a passo costante, in file ordinate. Alcuni portavano libri, altri bastoni. Nessuno parlava.
Mi fermai davanti a una piccola locanda con l’insegna “Alloggio Ruminante”.
Dentro, un odore di lana e fumo. Dietro al bancone, una donna anziana stava piegando asciugamani.
«Una stanza per la notte?» chiesi.
«Tutte le notti sono uguali qui, ma sì, gliela posso dare.»
La stanza aveva un letto di legno grezzo, una finestra aperta su un prato immobile. Dalla finestra si vedevano pecore sparse, ferme come sassi, rivolte tutte verso la stessa direzione.
Scendendo per cena trovai altri viaggiatori: due uomini in giacca chiara, una coppia silenziosa e un ragazzo che fissava il vuoto.
La padrona serviva zuppe dense e formaggi troppo forti. Durante il pasto, una delle pecore entrò lentamente nella sala, attraversò il pavimento e uscì dalla porta opposta. Nessuno disse nulla. Solo il ragazzo la seguì con lo sguardo, poi mormorò: «Qui capita spesso.»
Dopo cena uscii a camminare. L’aria era ferma, profumava di erba e terra fredda.
Dal margine del sentiero vidi una piccola scuola in pietra. Dalla finestra proveniva una voce che parlava piano. Mi avvicinai: dentro, una decina di pecore sedute ai banchi, una lavagna con parole scritte in gesso: Domande, Risposte, Ruminazione.
L’insegnante — anche lui una pecora, con occhiali spessi — spiegava qualcosa.
«Il pensiero non serve a capire,» diceva, «serve a stare fermi con dignità.»
Gli alunni belarono in tono approvante.
Più tardi, alla locanda, trovai la padrona seduta vicino alla stufa.
Le chiesi se era normale tutto questo.
«Certo. Qui tutto è molto chiaro. Solo chi arriva da fuori non se ne accorge.»
«E cosa fanno le pecore?»
«Riflettono. È la nostra tradizione. Da queste parti pensare troppo è un lavoro stagionale.»
Andai a dormire. Nella notte mi svegliò un rumore lieve: dal prato arrivava un mormorio, come un coro sommesso.
Guardai fuori. Le pecore erano ancora ferme, ma si muovevano appena, come se ripetessero la stessa frase senza voce.
Non capivo le parole, ma il ritmo era calmo, quasi rassicurante.
Al mattino il paesaggio era identico, come se la notte non fosse passata.
Quando chiesi il conto, la padrona mi diede una ricevuta bianca.
«Non è necessario scrivere nulla. Qui si paga restando un po’ più del necessario.»
Tornai al sentiero. Il treno non c’era più, ma una fila di persone camminava nella stessa direzione in cui ero arrivato.
Uno di loro, un uomo con la barba grigia, mi chiese se avevo visto la torre.
«Quale torre?»
«Quella che non si trova mai. La torre del Senso. Dicono che chi la vede smette di chiedere.»
Sorrise, come se fosse un segreto evidente.
Proseguii per qualche chilometro, finché il terreno cominciò a scendere. In lontananza si vedeva una distesa piatta, lucida come vetro. Un lago, forse.
Sul ciglio del sentiero un nuovo cartello:
“Lago Senza Fondo ma con Opinioni — cinque chilometri. Non discutete con l’acqua.”
Il sentiero scendeva piano, costeggiando campi vuoti e qualche recinzione crollata. Il terreno diventava sempre più umido, l’erba lucida di condensa. A tratti si sentiva un suono basso, ritmico, come un respiro enorme. Pensai fosse il vento, ma non c’era vento.
Dopo un’ora di cammino apparve il lago: una macchia grigia in fondo alla valle, circondata da canne alte e da alberi storti. Non era grande, ma dava l’impressione di non finire mai. L’acqua non aveva riflessi, solo un colore uniforme, metallico, come una superficie che finge di essere liquida.
Vicino alla riva c’erano alcune case basse, costruite con pietre scure. Sul primo muro, un’insegna scolorita:
“Trattoria del Pescatore Disilluso — Specialità del giorno, se c’è.”
Entrai per chiedere qualcosa da bere. Dentro, odore di fumo e di pesce vecchio. Un uomo anziano stava seduto al bancone, le mani intrecciate. Dietro di lui, alle pareti, file di lenze arrotolate e fotografie di barche vuote.
«È aperto?» chiesi.
L’uomo mi guardò come si guarda qualcuno che ha appena rotto il silenzio.
«A volte.»
«E oggi?»
«Oggi sì, ma non per molto. È giovedì.»
Mi versò un bicchiere d’acqua, poi si appoggiò al bancone.
«Viene per il lago?»
«Più o meno.»
«Lo faccia in fretta. Dopo un po’ comincia a parlarle.»
Pensai fosse una battuta, ma non rise. Pagai e uscii.
La riva era vicina. Camminando sull’erba sentivo un suono sordo sotto i piedi, come se sotto la superficie ci fosse qualcosa di vuoto. L’acqua sembrava ferma, ma avvicinandosi si muoveva appena, come la pelle di un animale addormentato.
Mi accucciai e toccai l’acqua con la punta delle dita: era fredda, ma più densa del normale. La superficie tremò, poi tornò immobile.
Un pescatore stava poco lontano, seduto su uno sgabello, con la lenza immersa a pochi centimetri.
«Prende qualcosa?» chiesi.
«Solo il tempo.»
Aveva un viso scavato e gli occhi chiari, quasi trasparenti.
«E funziona?»
«Ogni tanto. Ma qui il tempo non è stabile. Sale a galla, poi scompare.»
Non sembrava ironico. Tirò su la lenza: all’amo c’era un orologio da polso, gocciolante. Lo guardò, scrollò le spalle e lo gettò di nuovo nel lago.
Sulla riva, un altro cartello:
“Divieto di gettare oggetti nell’acqua. Ci penserà lei.”
Continuai a camminare lungo il perimetro. In certi punti il terreno franava, in altri affioravano pietre piatte, incise con frasi brevi.
“SONO STATO QUI”, “TROPPO TARDI”, “ERA QUASI GIUSTO”. Alcune lettere erano fresche, come appena incise.
Più avanti c’era un pontile di legno che entrava nell’acqua. Mi ci avventurai sopra. Ogni tavola scricchiolava come se protestasse.
In fondo, una panchina con due uomini seduti. Stavano immobili, lo sguardo fisso sul lago. Mi sedetti a qualche metro di distanza.
Dopo un po’, uno dei due parlò senza voltarsi.
«Si riflette meglio quando non si guarda.»
L’altro annuì lentamente.
Restammo così per un tempo indefinito. Il silenzio era denso, eppure non fastidioso.
Quando mi alzai per tornare, il primo uomo disse ancora:
«Se sente una voce, non risponda. È solo l’acqua che prova a convincerla.»
Risalendo il sentiero, il rumore basso che avevo sentito all’arrivo si era fatto più forte, come un motore lontano. Non c’erano barche, né vento. Forse era il lago stesso, o il terreno che si muoveva.
Mi voltai un’ultima volta: la superficie si increspava appena, e per un attimo mi parve di vedere il mio volto sull’acqua. Ma non rifletteva il movimento che facevo. Mi stava solo guardando.
Ripresi a camminare. Il sentiero proseguiva verso una distesa più scura, dove l’erba lasciava spazio alla sabbia e ai sassi.
Un nuovo cartello, inchiodato storto a un palo, indicava:
“Deserto della Connessione Instabile — 7 km.”
Sotto, qualcuno aveva aggiunto a penna:
“Il segnale è migliore se non si ha nulla da dire.”
Mi sistemai lo zaino e continuai a piedi, senza più voltarmi.
Il cielo restava fermo, e il rumore del lago mi seguì a lungo, come un respiro che non sapeva smettere.
Il sentiero si abbassava ancora, finché l’erba finì di colpo e cominciò una distesa di sabbia fine, color gesso.
Non c’erano alberi né ombra, solo qualche palo di legno piegato e una linea sottile di asfalto che tagliava l’orizzonte.
Ogni tanto si vedevano antenne arrugginite, alte e inutili, con fili pendenti che non portavano più da nessuna parte.
Un cartello, sbiadito, annunciava:
“Area di copertura parziale. Nessuna responsabilità per i silenzi prolungati.”
Il caldo non era forte, ma costante, come se il sole avesse deciso di restare in modalità moderata per tutto il giorno.
L’aria tremava appena, e da lontano pareva muoversi qualcosa: figure scure che si allungavano e si spezzavano sul terreno.
Quando mi avvicinai capii che erano cabine telefoniche.
Decine di cabine, disposte a file irregolari, alcune in piedi, altre rovesciate.
I cavi uscivano dal terreno come radici, spargendosi in tutte le direzioni.
Provai ad aprirne una. Dentro, il telefono era integro, la cornetta appesa, il vetro pulito.
Mi venne da sorridere: non ne vedevo una funzionante da anni.
Sollevai la cornetta, più per curiosità che per nostalgia.
Dall’altro capo si sentì un rumore bianco, poi una voce.
Era la mia.
«Pronto?» disse.
Rimasi immobile.
«Pronto?» ripeté.
Riattaccai lentamente.
Continuai a camminare, fingendo che non fosse successo niente.
Le cabine diventavano sempre più rade, finché scomparvero del tutto.
Il terreno si fece sabbioso e pieno di piccoli frammenti di vetro, lucidi, come sale.
Ogni tanto, un segnale acustico breve, simile al suono di un messaggio in arrivo, arrivava dal nulla, senza origine.
Era impossibile capire se venisse dal cielo o da sotto i piedi.
Più avanti incontrai una costruzione isolata: una stazione di servizio, perfettamente conservata ma priva di auto.
Le pompe erano coperte da teli grigi, la vetrina del bar intatta.
Dentro, luci accese e un bancone con bottiglie piene di sabbia.
Dietro al bancone, un uomo sui sessant’anni guardava un televisore spento.
«È aperto?» chiesi.
«Più o meno. La rete è debole oggi.»
«C’è qualcosa da bere?»
«Acqua, ma non garantisco il segnale.»
Riempì un bicchiere dal rubinetto e lo poggiò sul bancone.
Aveva il sapore normale dell’acqua, ma dopo aver bevuto mi sentii leggermente disorientato, come se avessi perso per un attimo la direzione del corpo.
Alle pareti, mappe turistiche della zona con punti di interesse cerchiati in rosso: Torre dell’Antenna Madre, Campo dei Router Antichi, Museo della Linea Persa.
«È lontano il museo?» chiesi.
L’uomo scrollò le spalle. «Dipende da quanti segnali trova lungo la strada. A volte è dietro l’angolo, a volte non esiste.»
Lasciai qualche moneta sul bancone. Lui le raccolse e disse piano:
«Se la connessione cade, non tenti di riconnettersi. Qui le disconnessioni durano più del previsto.»
Fuori, il cielo aveva perso un po’ di colore, come uno schermo che sta per spegnersi.
Camminai per un’ora buona senza incontrare nessuno.
Il silenzio era così pieno che sembrava fare rumore.
Poi, da dietro una duna, apparve una piccola carovana: cinque persone, ciascuna con un tablet legato al collo come una bussola.
Si fermarono accanto a me.
Il più anziano, un uomo con una barba scura e occhiali da sole, chiese:
«Ha segnale?»
«No.»
«Meglio. Significa che è arrivato.»
Non aggiunsero altro.
Si sedettero a terra, formando un cerchio, e cominciarono a fissare l’orizzonte come in attesa di qualcosa.
Li osservai per un po’. Nessuno parlava. Ogni tanto uno di loro sollevava il tablet, controllava lo schermo vuoto e lo riabbassava con aria soddisfatta.
Verso sera, comparvero delle luci basse, distribuite come un piccolo villaggio.
Quando mi avvicinai vidi che erano case fatte di metallo leggero, tutte uguali, illuminate da lampadine che pendevano direttamente dal cielo, senza fili.
Una donna stava seduta su una sedia fuori dalla porta, con un telefono in mano.
Mi salutò con un cenno.
«C’è posto per la notte?»
«Se resta fermo abbastanza, sì.»
«Ha un letto?»
«Due, ma uno è occupato da un aggiornamento in corso.»
Mi sistemò una branda vicino alla finestra.
Fuori, il deserto brillava in silenzio. Ogni tanto si accendeva un punto luminoso e poi spariva.
«Cos’è?» chiesi.
«Sono i pacchetti che si perdono. Non si preoccupi, qui finiscono tutti bene.»
Prima di dormire provai a guardare il telefono.
Segnale assente. Nessuna rete.
Eppure, per un secondo, comparve una notifica:
“Benvenuto. Rimanere disconnessi è il modo più stabile di esserci.”
Spensi lo schermo e mi sdraiai.
Il silenzio era perfetto, come se il mondo avesse finalmente deciso di smettere di trasmettere.
All’alba il cielo del deserto si era fatto chiaro, ma non luminoso.
Le dune erano scomparse, sostituite da una pianura compatta, arida come cemento.
Camminai seguendo una linea di pali bassi che indicavano una strada dimenticata.
Ogni tanto, ai lati, si vedevano resti di cartelli turistici: tavole spezzate, nomi cancellati dal sole.
Uno, ancora leggibile, diceva:
“Zona agricola sperimentale — Cantina del Buon Proposito, 3 km.”
La strada curvava tra cespugli secchi e filari di vigne ridotte a tronchi neri, ma perfettamente allineati.
Doveva esserci stata un’azienda vinicola, molto tempo prima.
A un certo punto apparve un grande edificio in pietra, mezzo interrato, con un’insegna di ferro battuto ancora lucida: Cantina del Buon Proposito.
Le finestre erano tutte chiuse, ma dalla porta socchiusa usciva un odore dolce, di vino e polvere.
Dentro era buio e fresco.
Le pareti rivestite di botti, scaffali ordinati, bottiglie coperte da uno strato sottile di ragnatele.
Su un bancone, un registro aperto mostrava un elenco infinito di nomi e date, ma tutte le colonne della destra, quelle dei numeri, erano vuote.
Un uomo anziano, vestito di scuro, sedeva su uno sgabello, immobile, con un bicchiere mezzo pieno.
«È aperto?» chiesi.
«Da sempre.» rispose, senza guardarmi.
«Posso assaggiare qualcosa?»
«Certo. Ma prima deve scegliere che cosa vuole dimenticare.»
Pensai di aver capito male.
«Come, scusi?»
L’uomo si alzò, camminò fino a uno scaffale e prese una bottiglia senza etichetta.
«Qui non vendiamo vino. Lo conserviamo. Ogni bottiglia contiene un proposito non mantenuto. Quando ne stappa una, si libera dello sforzo di ricordarlo.»
Mi porse il bicchiere.
«Questo, ad esempio, è del tipo “Da lunedì comincio”. È leggero, ma lascia un retrogusto di colpa.»
Assaggiai.
Il sapore era buono, più rotondo del previsto, ma con un amaro in fondo, quasi familiare.
«Interessante,» dissi.
Lui annuì. «Molti lo trovano consolatorio. Ma non bisogna esagerare: dimenticare troppo porta sete.»
Camminammo tra le botti. Su ognuna era inciso un titolo: Telefonerò a mia madre, Cambierò lavoro, Basta pensare a lei, Quest’anno palestra.
Alcune erano segnate con una croce bianca.
«Quelle?» chiesi.
«Promesse collettive. Più difficili da far evaporare.»
In fondo alla sala, un portone di legno conduceva a una galleria scavata nella roccia.
L’uomo mi invitò a seguirlo.
Dentro, centinaia di bottiglie disposte in nicchie perfettamente uguali.
Ciascuna aveva un’etichetta scritta a mano.
Mi fermai a leggerne alcune: Progetto lasciato a metà, Decisione rinviata, Buona intenzione con testimoni.
«È impressionante,» dissi.
«Non è ancora niente. Queste sono solo le annate recenti.»
In fondo alla galleria c’era una botola aperta.
Sotto, il buio più totale.
«E laggiù?»
«Lì finiscono quelli che non hanno mai iniziato.»
Chiuse la botola piano, quasi con rispetto.
Tornammo verso la luce.
Sul banco, due bicchieri puliti e una nuova bottiglia già pronta.
«Questa è una riserva speciale,» disse. «Si chiama Lasciar perdere con eleganza. Non tutti sono pronti.»
Mi riempì il bicchiere.
Bevetti piano.
Il gusto era diverso: chiaro, asciutto, quasi gentile.
Mi sentii leggero, ma non felice. Come quando si accetta qualcosa senza capire se sia una resa o un sollievo.
«Posso comprarne una?» chiesi.
L’uomo scosse la testa.
«Non si può vendere il sollievo. Al massimo lo si degusta.»
Appoggiò una mano sulla botte più vicina e aggiunse:
«Ma se vuole, può lasciare la sua. Tutti lo fanno, prima o poi.»
Mi porse un’etichetta bianca e una penna.
Senza pensarci troppo, scrissi:
“Trovare un motivo per partire.”
Lui sorrise appena, prese l’etichetta e la fissò su una bottiglia vuota.
«Ottimo vintage. Resisterà a lungo.»
Quando uscii, il sole era già basso e il deserto sembrava più chiaro.
Camminai fino alla strada.
Dietro di me, il vento portava l’odore del vino e un suono lieve, come tappi che saltano piano.
Davanti, l’orizzonte tornava a farsi confuso, e per la prima volta mi parve un buon segno.
La strada dopo la cantina scendeva verso una valle piatta, attraversata da un fiume lento e largo.
Sulle sponde crescevano canneti e rovine: resti di ponti, cancelli arrugginiti, segnali stradali rivolti in direzioni incompatibili.
Più avanti, l’asfalto tornava liscio, nuovo, con cartelli lucidi e lampioni in ordine.
Su uno di essi, una freccia chiara indicava:
“Specchiarisi – Città gemella di se stessa.”
Entrando, la prima impressione fu di perfetta normalità.
Palazzi moderni, vetrine pulite, linee del tram, gente per le strade.
Solo dopo qualche minuto mi accorsi che qualcosa non tornava.
Ogni facciata rifletteva la luce in modo strano, come se fosse coperta da uno strato di vetro invisibile.
Camminando, mi vidi decine di volte: nei portoni, nelle vetrine, perfino nei parabrezza delle auto.
Il mio riflesso compariva sempre un attimo dopo di me, e non sempre con la stessa espressione.
In un bar d’angolo, con l’insegna “Caffè Identico”, i tavolini erano occupati da persone che parlavano piano, ma sembravano farlo solo per non sentirsi sole.
Seduto al bancone, chiesi un espresso.
Il barista, un uomo elegante con un sorriso studiato, rispose:
«Già preso, pochi minuti fa.»
«Non credo.»
«Controlli meglio.»
Indicò il ripiano davanti a me: c’era effettivamente una tazzina vuota, con ancora un filo di schiuma.
Il manico era girato verso destra, proprio come faccio io.
Pagai in fretta e uscii, senza voltarmi verso la vetrina.
Fuori, la gente camminava come in un flusso ben coreografato.
Nessuno urtava nessuno, ma tutti sembravano occupati a tenere d’occhio la propria immagine riflessa.
Ogni tanto qualcuno si fermava davanti a una vetrina, non per guardare, ma per aggiustarsi.
Non i capelli, non i vestiti — l’espressione.
Come se ci fosse un modo giusto di apparire a se stessi.
Più avanti trovai un grande edificio di marmo bianco, con un’insegna discreta: Museo dell’Io.
Entrai.
L’atrio era silenzioso, pieno di schermi accesi.
Ogni visitatore aveva davanti un monitor con la propria immagine in tempo reale.
Un ragazzo, accanto a me, fissava il suo riflesso con aria confusa.
Dallo schermo proveniva una voce metallica:
“Per un’esperienza più autentica, la preghiamo di essere spontaneo.”
Mi spostai verso una sala laterale.
C’erano specchi ovunque, ma deformanti in modo impercettibile: uno ingrandiva lo sguardo, un altro piegava leggermente la postura, un terzo cambiava il ritmo del respiro.
In mezzo, una guida con una giacca grigia stava spiegando qualcosa a un gruppo di visitatori.
«Qui esponiamo la verità filtrata. Ognuno la riconosce, ma non sa quale sia.»
Una donna del gruppo alzò la mano.
«E se non mi riconosco?»
La guida sorrise.
«Allora ha trovato la sezione corretta.»
Salii al piano superiore.
C’era una sala completamente vuota, illuminata da un’unica finestra.
Sul muro di fondo, un grande specchio coperto da un telo bianco.
Un cartello diceva:
“Specchio autentico. Si raccomanda discrezione.”
Sollevai appena il telo.
Non vidi me stesso, ma una stanza uguale a quella in cui mi trovavo, solo più buia.
Al centro, una figura voltata di spalle, ferma.
Quando il telo mi scivolò dalle mani, la figura si mosse.
Chiusi gli occhi, poi riabbassai il tessuto.
Non c’era più nulla.
Uscendo dal museo, la luce del pomeriggio era diventata fredda.
Tutti i palazzi riflettevano un bagliore uniforme, come se la città intera fosse fatta di specchi spenti.
Cercai un’uscita, ma le strade sembravano ripetersi.
Alla fine, un sottopasso mi riportò al margine del paese, dove l’asfalto finiva nel fango.
Un cartello inclinato avvisava:
“Uscita da Specchiarisi. Guardarsi dopo, non prima.”
Mi voltai una sola volta.
Dietro di me, la città sembrava perfettamente immobile, come se stesse trattenendo il respiro.
Presi l’unica strada asfaltata che puntava verso nord.
Non c’erano indicazioni, ma il paesaggio cominciava a diventare familiare.
Colline basse, paesi lontani, odore di pioggia.
Avevo camminato per ore quando vidi, in fondo, una piccola stazione ferroviaria.
Non c’era scritto niente sull’edificio, solo una pensilina e un orologio fermo.
Sulla panchina, un giornale piegato con la data di quella mattina.
Mi sedetti accanto e aspettai.
Il treno arrivò in silenzio, un convoglio grigio con i vetri opachi.
Nessuno scese, nessuno salì, ma le porte si aprirono.
Entrai in uno scompartimento vuoto.
Mi sedetti e chiusi gli occhi.
Quando li riaprii, il paesaggio scorreva al contrario: il deserto, l’altopiano, la città, tutto tornava indietro, ma con colori diversi, più spenti.
Riconobbi persino la stazione di partenza, identica, ma senza cartelli.
Il treno si fermò.
Scesi.
Il binario era deserto.
Camminai fino all’uscita.
Il cielo era lo stesso di sempre, un po’ grigio, un po’ incerto.
Davanti a me, un chiosco di giornali chiuso, un taxi che aspettava senza autista, un cane seduto che mi guardava come se mi riconoscesse.
Aprii il taccuino per scrivere qualcosa, ma non trovai le parole.
Poi, quasi da solo, il pennino tracciò una frase:
“Sono tornato. Ma non sono sicuro di dove.”
Chiusi il quaderno e mi avviai verso la strada.
Le vetrine riflettevano la luce del tramonto.
In una di esse, per un attimo, mi sembrò di vedere qualcuno che mi salutava.
Aveva il mio volto, ma un’aria più serena.
Forse non era un brutto finale, pensai.
Forse, dopotutto, era solo un ritorno riuscito male.
E continuai a camminare.

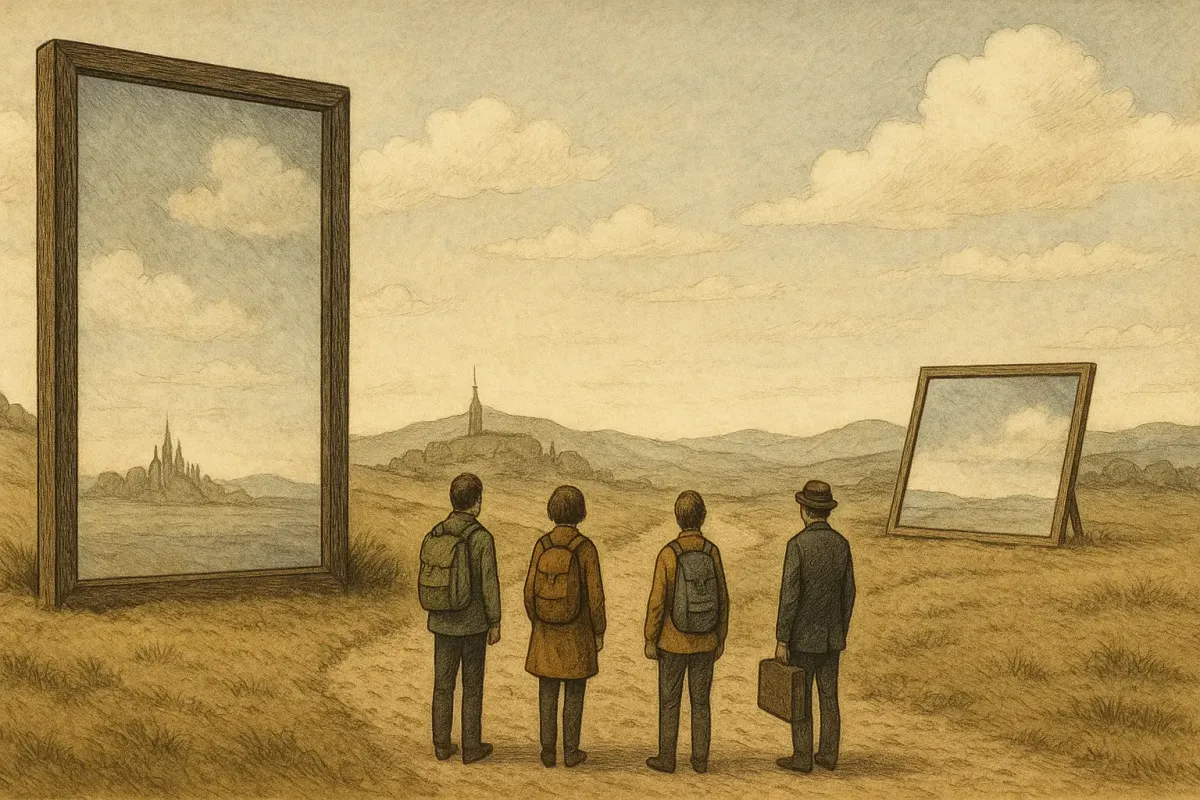

Comments ()