Il gran giorno! La fuga dal Palé!

Sveglia. Non la dolce sveglia di un hotel di charme, con la luce che filtra e un cameriere che bussa piano con il vassoio della colazione. No. Qui la luce entra come una guardia carceraria che spalanca la porta alle 5 del mattino e ti urla di prepararti alla perquisizione.
Mi alzo, già vestito con gli stessi pantaloni di ieri perché non ho avuto il coraggio di aprire la valigia: temevo che durante la notte qualche entità del Palé ci avesse infilato dentro una maledizione, o peggio, un pasto cucinato da loro.
A colazione, sorpresa: oggi il pane tostato arriva prima della fine della colazione! Non ci credo. Forse hanno letto il mio diario di ieri. Ma c’è la fregatura: Maddalena non è con noi (lei alloggia nella sua camera “superior”, che in realtà è un piccolo castello con fossato privato e servitori in livrea), e senza di lei il pane tostato è… triste.
Non “pane poco buono”. No, questo sembra avere malattie ottocentesche: rachitismo, sifilide, e forse un principio di peste bovina. Lo guardo e ho l’impressione che stia tossendo.
Ma non importa. Oggi non si mangia: oggi si fugge. Carichiamo le valigie come in un film di guerra — Maddalena lancia dentro zaini, Sara chiude il bagagliaio a spinta, io guardo lo specchietto per vedere se il Palé ci insegue come un’entità Lovecraftiana.
La strada più stretta del Galles
Il piano è semplice: un po’ di miglia in auto fino a un trekking sull’Offa’s Dyke, con castello diroccato. In teoria facile.
In pratica, a un certo punto lasciamo la “strada principale” (che qui è larga quanto una pista ciclabile di Milano) per infilarci su una stradina che definire stretta è un eufemismo.
Immagina la scena: io al volante, Sara accanto che cerca di distrarmi con frasi tipo “Guarda che bel panorama” (che non vedo perché sto cercando di capire come evitare che la portiera entri nell’orbita terrestre), e Maddalena dietro che si diverte a fare l’effetto sonoro del metallo che striscia sulle rocce.
Ogni macchina che incrociamo è un duello di nervi. Non c’è spazio per due auto, ma qui, misteriosamente, entrambe devono passare. Allora si comincia: marcia indietro, sterzo tutto a sinistra, poi avanti di 10 cm, poi indietro di 7 cm, finché il contatto tra i nostri specchietti e la siepe non produce un odore di clorofilla bruciata.
Dopo 30 minuti di tensione degni di un thriller scandinavo, sbuchiamo sulla Panorama Walk. Un miracolo: tutte e quattro le ruote sull’asfalto contemporaneamente. Mi commuovo.
Trekking: la moquette delle pecore
Parcheggiamo in un piccolo spiazzo che, a giudicare dalla segnaletica sbiadita, potrebbe essere un parcheggio ufficiale o il cortile di una fattoria dismessa nel 1874. Infilo gli scarponi con la solennità di un alpinista che sta per tentare l’Everest, anche se l’altimetro dell’auto segna 312 metri.
Partiamo subito in salita. Non una salita infinita, ma di quelle che, dopo dieci passi, ti fanno domandare: “Ma non c’era una funivia?” Dopo due minuti sento già il battito nelle orecchie e immagino che il mio corpo stia inviando un SOS a qualche centro di soccorso alpino in Svizzera.
Arriviamo presto a quella che chiamo “quota di volo”: il vento ti prende, ti solleva i capelli (anche se, come me, non li hai) e ti porta dritto nelle narici il profumo inconfondibile del pascolo: un misto di erba fresca, fiori selvatici e, come nota di fondo, cacca di pecora stagionata.
Il sentiero sotto i piedi è talmente morbido e uniforme che, per un attimo, sono sicuro di camminare su moquette. E infatti… lo è. Non la moquette comprata all’Ikea, ma quella pregiata, fatta a mano (o meglio, a zoccolo).
A un certo punto, su un muretto a secco, incontriamo due pecore anziane sedute come vecchie sarte in una bottega. Una lavora a maglia, l’altra si lima lo zoccolo sinistro con calma olimpica. Mi spiegano che loro, ogni giorno, percorrono avanti e indietro la cresta per “battere” il terreno e renderlo più confortevole ai turisti. Una di loro, che dice di chiamarsi Margaret, mi guarda dritto negli occhi e mi chiede, con accento leggermente scozzese, se sono lì per la “Conferenza annuale sulla lana idrorepellente”.
Non faccio in tempo a rispondere che l’altra, Edith, si lamenta del fatto che quest’anno la moquette ha avuto troppa umidità e che, se i turisti non imparano a pulirsi gli scarponi, lei smette di fornire il servizio. Annuisco con la serietà di chi sa che, senza il loro lavoro, qui sarebbe tutto un pantano.
Proseguiamo in cresta. È un sentiero largo, con una vista che ti fa sentire in cima al mondo, anche se in realtà sei circondato da colline così tonde che sembrano create con lo stampo per cupcake. Davanti a noi, come in una cerimonia medievale, due pecore in abito da festa ci aprono la strada: una con un fiorellino giallo dietro l’orecchio, l’altra con una sciarpa a righe bianche e nere che le dona un’aria vagamente francese.
Ogni tanto si fermano, si voltano e, con aria severa, ci intimano (in un linguaggio che solo noi e i pastori locali possiamo capire) di non calpestare i “punti a croce” del prato, che loro hanno ricamato con precisione certosina in mesi di lavoro. Sara, colta da entusiasmo artistico, chiede se vendono anche centrini da tavolo; le pecore la ignorano, offendendosi profondamente.
La discesa è improvvisa: un pendio verde che si stende davanti a noi come un tappeto rosso di gala. Per un attimo immagino di essere a Cannes, sfilando tra flash e applausi, solo che al posto dei paparazzi ci sono corvi e pecore che masticano rumorosamente. In pochi minuti siamo di nuovo alla macchina, con quella sensazione di trionfo che si prova quando hai fatto qualcosa di apparentemente epico… che in realtà era una passeggiata di due ore in collina.
No, la strada dell’andata non la rifaccio — la trattativa dell’anno
Arrivati alla macchina, sudati ma trionfanti, Sara prende la cartina (che nessuno usa mai, ma lei la tiene per dare un tono “old school” alle decisioni di viaggio) e dice:
— “Ok, torniamo da dove siamo venuti: è più veloce.”
Io mi blocco. Giro la testa lentamente, come nei film in cui l’eroe scopre che il compagno è in realtà il cattivo.
— “Da dove siamo venuti…? Quella… stradina? Quella maledetta fessura tra due siepi che chiamano road?”
Maddalena, che sta già bevendo dalla borraccia, annuisce come se fosse una cosa ovvia:
— “Sì, ci mettiamo la metà del tempo.”
Io respiro a fondo. Lo sguardo si fa serio. Inizio il discorso come un diplomatico in una crisi internazionale:
— “Ascoltatemi bene: io, da quella strada, non ci passo più. Piuttosto… mi faccio adottare dalle pecore. Ho già parlato con Margaret, mi hanno promesso un posto nella loro comunità, un giaciglio in lana e un tè alle cinque. È un’offerta seria.”
Sara ride. Pensava fosse una battuta. Capisce che non lo è quando mi vede già con il maglione di lana ruvida e un campanaccio al collo.
Parte la negoziazione:
— “Ma guarda che era solo una strada stretta, niente di che…”
— “Niente di che?!? Era una trappola medievale per punire i ladri di bestiame! Ti ricordo che abbiamo dovuto piegare lo spazio-tempo per far passare la macchina. Credo di aver sfiorato la terza dimensione di un’altra galassia solo per evitare lo specchietto di una Ford Fiesta.”
Maddalena, con tono da avvocato della difesa:
— “Ma pensa che soddisfazione: se la rifacciamo, magari va meglio.”
Io:
— “Meglio?!? La prossima volta non ci esco vivo. Mi vedranno passare al telegiornale: ‘Italiano bloccato in stradina gallese, liberato dopo tre giorni da squadra specializzata in pecore aggressive’.”
Sara prova il colpo basso:
— “Ma è più panoramica.”
— “No, la Panorama Walk è panoramica. Quella è un’angioplastica per la macchina.”
Il dibattito continua, si passa ai ricatti morali (“Stai allungando il viaggio!”), alle minacce velate (“allora guidi tu!”) e infine alle ipotesi estreme (“Potremmo smontare la macchina e rimontarla dopo”).
Alla fine, io pianto i piedi come un bambino di 6 anni davanti al banco dei gelati:
— “O si fa la strada panoramica o io mi accampo qui. E sappiate che so fare il verso della pecora. E anche della capra, se serve.”
Silenzio.
Sara e Maddalena si guardano. Capiscono che ho raggiunto il livello di testardaggine in cui potrei davvero tirare fuori una tenda e un fornelletto da campo.
Cedono.
Prendiamo la Panorama Walk. Non è un’autostrada, ma è un paradiso: due auto che si incrociano senza scendere nei fossi, ruote che non sfregano contro le siepi, e soprattutto… niente trauma post-stradina.
Chirk: hamburger medievali e lingue straniere
Arriviamo a Chirk con l’aria di chi è sopravvissuto a una spedizione artica, anche se abbiamo solo camminato un paio d’ore in collina. Sara ha trovato per noi il Castle Bistró, un ristorantino dall’aspetto rassicurante, con tavolini in legno, menu plastificato e quell’odore di cucina internazionale che mescola burro, carne alla griglia e un leggero sentore di mistero.
Apriamo il menu: piatti esageratamente complessi, nomi in inglese e in italiano (più o meno). Io e Sara ci guardiamo: “Proviamo l’hamburger”.
La cameriera annuisce con un sorriso che oggi capirò essere un segnale di pericolo. Quando arrivano i piatti, capiamo l’errore: non sono hamburger… sono monumenti commemorativi.
Pane grosso come la ruota di un carretto, carne alta come un dizionario Zanichelli, bacon disposto in strati geologici e formaggio fuso in quantità tale che, se raccolto, potrebbe ricoprire l’intera facciata del Big Ben.
Assaggio il primo morso e mi chiedo se questo fosse il pasto che nel medioevo i feudatari offrivano agli operai che costruivano le mura: “Ecco, mangiate questo e potete lavorare per altre tre settimane senza stipendio”.
Maddalena, nel frattempo, ha ordinato una bruschetta. La cameriera, con la sicurezza di chi ha studiato all’Accademia Internazionale della Pronuncia Creativa, la chiama “bruscietta”.
A quel punto non possiamo tacere: parte una lezione di fonetica improvvisata. Sara prende un tovagliolo, ci scrive sopra “BRUSCHETTA” in maiuscolo, io faccio esempi con altre parole (“come scheda, non scietta!”), Maddalena corregge con pazienza britannica. La cameriera ci ascolta, annuisce, e poi, con lo sguardo di chi ha appena imparato un segreto dell’universo, ripete: “Bruschet-ta”. Applauso.
Al momento di pagare, mi avvicino alla cassa. Visti i nomi italiani nel menu, chiedo al proprietario:
— “Siete italiani?”
Lui mi guarda con aria serissima e dice:
— “No, sono della Turchia.”
Silenzio di tomba. Poi, quasi per rassicurarmi:
— “Però conosco un pizzaiolo a Cardiff.”
E, con questa frase, tutti i misteri linguistici e gastronomici del locale trovano una loro logica distorta.
Chirk Castle e la maledizione del Palé
Dopo pranzo, ci dirigiamo verso Chirk Castle, pronti alla possibilità di una delusione. Ricordiamo bene lo “Stirling Castle incident” dell’anno scorso: mura scenografiche, negozio di souvenir, caffetteria… ma zero stanze visitabili.
Invece no: qui ci accoglie un vero castello.
Si entra attraverso un cortile curatissimo, poi si attraversano sale piene di mobili d’epoca, arazzi, quadri di antenati che ti seguono con lo sguardo (probabilmente per assicurarsi che tu non rubi le posate d’argento). Ci sono camere da letto sontuose, cucine con pentoloni che sembrano usciti da una fiaba e corridoi che odorano di legno antico e cera.
Siamo eccitati: alla fine del percorso, si possono visitare i dungeons, le prigioni sotterranee! Non ci siamo mai stati, sarebbe la nostra prima volta. Immaginiamo già catene arrugginite, vecchie torce, magari qualche leggenda di fantasmi.
E invece… un cartello. “Dungeons closed for maintenance.”
Il custode, con un’espressione che sembra dire “Non è colpa mia”, ci spiega che stanno “lavorando alla sicurezza degli accessi”. Io traduco: “Stanno cercando di capire come riaprire senza che i turisti si portino via un muro come souvenir.”
Ma la verità la sappiamo: è la maledizione del Palé. Quella forza oscura che fa sì che, ovunque andiamo, qualcosa di importante sia chiuso. Una costante cosmica. Se domani andassimo a Stonehenge, troveremmo un cartello: “Cerchi in manutenzione, riapertura prevista nel 2054”.
L’hotel delle nozze e la stanza glaciale
Rookery Hall Hotel & Spa. Nome elegante, suono rassicurante. Arriviamo dopo un’ora di stradine e, convinti di essere ormai viaggiatori esperti, parcheggiamo… nel posto sbagliato.
Con le nostre valigie rullanti e gli zaini, entriamo baldanzosi nel primo edificio. Appena dentro, capiamo che qualcosa non quadra: camerieri che girano con flûte di champagne, fiori freschi ovunque, musica dal vivo.
Poi vediamo gli sposi. Lei in abito bianco, lui in tight, circondati da invitati vestiti di tutto punto.
Noi: pantaloni da trekking infangati, scarponi pesanti, capelli modellati dal vento come sculture moderne. Maddalena, con aria di orgoglio, mi sussurra che sulla felpa ha una “collezione museale” di cacche di pecora in ordine cronologico, tipo esposizione didattica per bambini delle elementari.
Ci muoviamo tra i tavoli come in una missione sotto copertura, cercando di non attirare l’attenzione. A un certo punto, un cameriere con passo deciso si avvicina con un vassoio e io, per un attimo, temo che ci stia offrendo da bere e che, nel momento stesso in cui accettiamo, verremo ufficialmente considerati ospiti del matrimonio. Panico.
Riusciamo a defilarci e usciamo di corsa, prima che qualcuno ci chieda di unirci al valzer o di firmare il libro degli ospiti.
Finalmente troviamo l’edificio giusto. La reception è elegante, con musica di sottofondo e un profumo che sa di fiori e soldi. Ci avviciniamo al bancone e inizia il check-in più lungo della storia.
Per qualche ragione, la receptionist è costretta – per policy aziendale, a suo dire – a cliccare il tasto sinistro del mouse 192 volte per ogni ospite. Non sto scherzando. Dopo un po’ sono convinto di averla vista eseguire movimenti lenti e circolari, come se stesse facendo Tai Chi tra un clic e l’altro. Credo abbia anche consultato le fasi lunari prima di passare alla schermata successiva.
Maddalena ottiene la camera 26. Noi, invece, niente numero: la nostra stanza si chiama “January”.
Entriamo e capiamo subito perché: aria condizionata a 16 gradi fissi, poltrone in cui puoi congelare comodamente e un’atmosfera da rifugio polare. La professionalità sta nel branding: non oso immaginare la stanza “August” – probabilmente 45 gradi, vento sabbioso e un dromedario in salotto.
Relax e silenzio (sul Palé)
Dopo una doccia bollente che ci restituisce la vita e un letto talmente comodo che sospetto sia imbottito di piume di fenicottero allevati a mano, ci sentiamo finalmente umani.
Alle 19:30 scendiamo al ristorante dell’hotel. Cena discreta, con porzioni che non pretendono di sfamare interi reggimenti ma nemmeno di farti chiedere una pizza alle 23. Bella carta dei vini, atmosfera elegante.
Poi decidiamo di spostarci nel giardino: l’erba è tagliata alla perfezione, i cespugli sagomati in forme geometriche improbabili, e c’è quell’aria serale che sa di tregua dopo la tempesta.
Seduti lì, iniziamo il resoconto della giornata: ridiamo delle stradine, degli hamburger mostruosi, della fuga dal matrimonio. Ci permettiamo anche qualche pettegolezzo su viaggi passati, su personaggi incontrati e su episodi che, se raccontati al Palé, farebbero chiudere il posto per sempre.
La regola della serata, però, è chiara: non si pronuncia la parola proibita. “Palé” è come “Voldemort”: nominarlo potrebbe evocarlo. Parliamo di “lì” o “il posto di cui non si parla”.
E così, tra un bicchiere di vino e l’altro, ci sentiamo finalmente liberi.
Quando saliamo in camera, il silenzio è totale. Si sente solo il rumore dell’aria condizionata che sforna freddo come se stesse rifornendo un igloo. Ci infiliamo sotto le coperte e in pochi minuti… nanna. Stanchi, ma finalmente sereni.



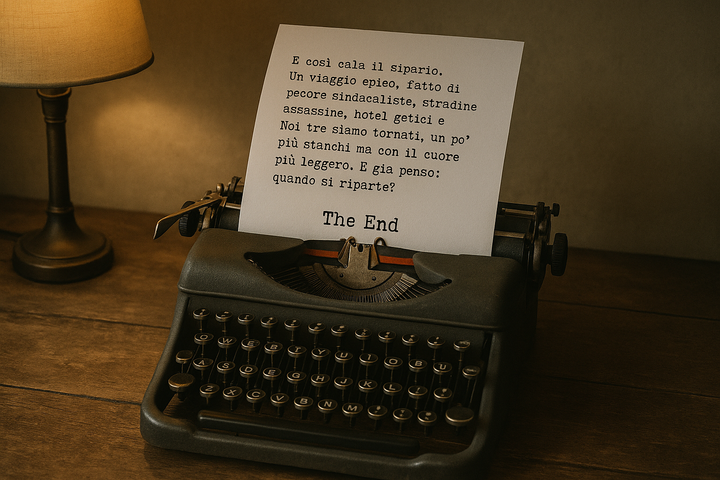
Comments ()